di Matteo Torani
Comparsa per la prima volta nel 1817, la parola viene dal latino virus con cui ci si riferiva al “succo, al veleno delle piante” e più avanti all’ “umore”, al veleno degli animali. È interessante notare come la parola latina virus sia associata alla radice indoeuropea *weis- (fluire, veleno) e con il greco ἰός (ios = veleno). La parola venne usata per la prima volta dal chirurgo francese Paré nel XVI secolo per indicare il “pus contagioso e corrosivo di una piaga”, e da quel momento entrò a far parte del gergo scientifico internazionale; solo più tardi comparvero invece i suoi derivati virulento e virulenza.
Quasi esclusivamente confinata al campo dell’informatica già da circa trent’anni, tanto da essere per lo più associata e usata insieme al prefisso anti-, negli ultimi mesi la parola virus sembra essersi ormai del tutto svincolata dal mondo digitale per tornare con tutta la sua virulenza semantica nel mondo dell’aldiquà. Come ci si poteva immaginare, oltre a mietere molte vittime, far collassare i sistemi sanitari di mezzo mondo e mettere in ginocchio intere economie, la parola che lo identifica è arrivata a contagiare il nostro “sistema immaginario”. Sebbene la maggior parte di noi sta bene, è negativa, non è asintomatica né altro, d’altro canto è indubbio che il virus ci si è ficcato in testa. Che sia per colpa della cosiddetta infodemia che ormai respiriamo continuamente da mesi, o per la semplice necessità di gestire psicologicamente ed emotivamente questo tempo distorto, questo animaletto di cinque lettere sta lì, al posto di comando delle nostre coscienze: da lì forgia i nostri pensieri, modella i nostri sentimenti; avviluppa il nostro desiderio di relazione con l’altro fino, in alcuni casi, a spegnerlo del tutto; struttura una fitta rete di paure che a loro volta manovrano pratiche domestiche ed extradomestiche che, per adempiere alle misure di sicurezza emanate dal Governo, si sono ormai trasformate essenzialmente in un’infinità di rituali profilattici.

Epicentro, fulcro e vettore di qualsiasi discorso pubblico privato, politico mediatico e per giunta religioso, ha fatto molto di più che contagiare circa due milioni di persone e ucciderne circa 120 mila in tutto il mondo: ha viralizzato le mente delle altre 7.698.000.000, su per giù. In appena tre mesi è diventato un chiodo fisso, il nuovo pensiero unico. Lungi dall’essere una forma molto in voga per riferirsi a qualcosa che monopolizza l’attenzione, quello di pensiero unico è un concetto filosofico elaborato originariamente da Arthur Schopenhauer e che successivamente fu ripreso da altri pensatori. Tra essi Herbert Marcuse, il quale parlava di qualcosa di simile chiamandolo pensiero unidimensionale. Nel riprenderne la definizione l’ho trovata incredibilmente adatta al momento attuale. Secondo il filosofo tedesco, il pensiero unidimensionale si impone come conseguenza della “chiusura dell’universo del discorso” imposto dalla classe politica dominante e dai mezzi di comunicazione: “il suo universo del discorso è popolato da ipotesi che si autovalidano le quali, ripetute incessantemente da fonti monopolizzate, diventano definizioni o dettami ipnotici”.
Ora, al di là delle cifre (curva dei contagi e numero di deceduti) e delle misure di sicurezza, il resto della narrativa relativa alla diffusione del coronavirus, non sembra molto più legata all’ambito delle ipotesi che a quello della certezza? Si pensi ad esempio all’efficacia delle mascherine, al fatto che c’è stato chi – poi puntualmente smentito – sosteneva che potrebbe regredire con l’innalzarsi delle temperature; si pensi al metro… e mezzo… e ottanta, vabbè facciamo due, insomma alla “giusta” distanza di sicurezza da mantenere con gli altri, alla contagiosità degli asintomatici, ai tempi di resistenza sulle superfici, per non parlare poi della questione cruciale relativa alla naturalità o artificiosità del passaggio dal pipistrello all’essere umano. Ipotesi, appunto. Trite e ritrite dai media durante l’intero arco della giornata, nella nostra mente hanno finito per assumere quella forma di certezze inconfutabili che a volte solo le ipotesi più spaventose arrivano ad avere. Ipotesi e paure ci hanno trascinati all’interno di uno stato di ipnosi globale che, come se non fosse sufficiente di per sé, è stata accompagnata dall’impennata del consumo di contenuti multimediali.

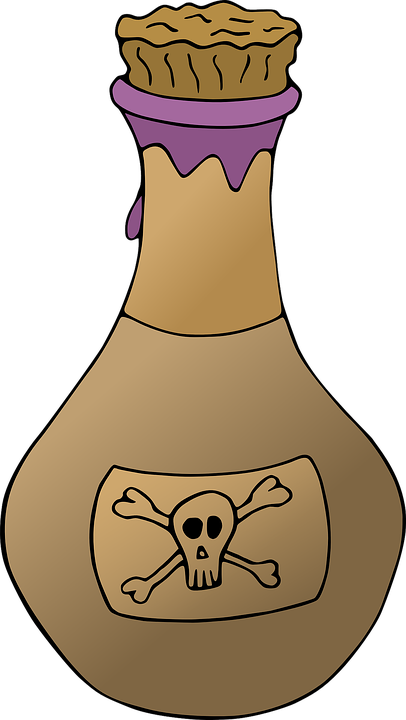
Ora, tornando all’origine della parola virus, a cosa può servirci la sua etimologia? Credo sia interessante evidenziare la sua relazione con la parola veleno. Quest’ultima a sua volta viene dal latino venenum, parola con cui ci si riferiva a una “pozione magica” e che è relazionata alla radice indoeuropea *wen- (amare, venerare), da cui derivano anche le parole venerare, Venere, venerando (en espressioni come, ed esempio, veneranda età). Scopriamo così che se percorriamo a ritroso la parabola semantica della parola virus ci ritroviamo nel territorio dell’occulto – nel senso di nascosto, di ciò che non può essere visto –, dell’estraneo, del sovrumano, al tempo stesso sacro e temuto. A prescindere dall’essere credenti, animisti, atei o agnostici, siamo tutti culturalmente familiarizzati con l’idea del venerare (mostrare un profondo ossequio) qualche entità invisibile, ubiqua, onnipotente, quintessenza del bene, mastro burattinaio del destino umano, arbitro della vita e della morte. Indipendentemente da quella che è il nostro credo, o dal fatto che ne abbiamo o meno, quelle religiose, sono di fatto coordinate di pensiero estremamente potenti che tutti padroneggiamo e che fanno sì che determinati discorsi e narrazioni ci risultino intellegibili. Oggi, a mio avviso, il coronavirus sta subendo, tra le altre, una semantizzazione simile, opposta e complementare a quella di dio, in quanto ugualmente invisibile, potenzialmente ubiquo, onnipotente, quintessenza del Male, mastro burattinaio del destino dell’umanità, arbitro della vita e della morte. Ho finito per convincermene dopo aver seguito con estremo interesse alcune celebrazioni che hanno accompagnato quest’ultima quaresima – o cuarentesma, come è stata rinominata molto acutamente da alcuni utenti social ispanofoni –, così come le omelie di alcuni sacerdoti che hanno continuato a svolgere il loro uffizio tramite internet e ascoltando alcuni discorsi di pastori e telepredicatori i cui sermoni su come far fronte al coronavirus spopolano su YouTube.

In un certo senso è proprio questo ciò che stiamo facendo: stiamo venerando il coronavirus, mostrandogli tutto il nostro rispetto, ossequio e timore. E se da una parte è comprensibile se non addirittura imprescindibile per riuscire a sconfiggerlo, dall’altra comporta molti rischi, tra cui la perdita o il logorio del nostro arbitrio. Dopo aver mandato giù la pozione magica, esserci narcotizzati a suon di telegiornali, programmi di approfondimento, bollettini delle 18, etc., abbiamo fatto accomodare il pensiero unidimensionale in salotto e abbiamo sbattuto la porta dall’interno. Adesso ci troviamo qui, soli, immobili, avvitati al divano, ipnotizzati, come pecorelle di un gregge globale, al tempo stesso smarrite e alienate, molti di noi con i tipici sintomi della depressione – noia, stanchezza cronica, ansia, mancanza di concentrazione, svogliatezza, disturbi del sonno – e intrattenuti come mai prima d’ora da infinità di contenuti multimediali che nemmeno due vite intere passate in quarantena basterebbero per poterli consumare. E con quell’animaletto di cinque lettere che continua a stare lì, al posto di comando, ora sì è proprio il caso di dirlo, della nostra incoscienza.


Credo sia necessario riappropriarci delle nostre coscienze, con rispetto, responsabilità e senso civico, ovviamente. Per fare in modo che il tempo passi senza consumarci e che il nostro spirito rompa le pareti del confinamento, sarebbe sufficiente imitare ciò che la natura fa da sempre in modo così delicato e silenzioso in questo periodo dell’anno: si ricrea, risuscita, risorge. Riprendiamo contatto con la nostra creatività, letteralmente la “capacità di creare”, ciascuno attingendo dai propri talenti: la musica, gli origami, la pittura, il bricolage, la recitazione, la cucina, la danza, la poesia… Ciascuno di noi ne ha. E se lo facciamo per qualcun altro, ancora meglio. Assecondiamo la primavera affinché le sue giornate condiscano di stimoli il nostro tempo. Di tanto in tanto smettiamola di credere acriticamente in tutto ciò che ci viene raccontato, e iniziamo a credere e a creare un pochino di più in prima persona, proprio come si fa in spagnolo. Yo creo.
E se poi passiamo alla prima persona plurale, visto che come ho letto da qualche parte, l’Io non è altro che un’emanazione del Noi, lo spagnolo ci regala un ulteriore suggestione. Perché quello che succede all’indicativo mentre creiamo qualcosa, ovvero mentre crediamo in noi stessi, al congiuntivo si rovescia nell’altro proprio nel momento in cui lo trasformiamo esortazione. ¡Creemos! E viceversa. ¡Creamos!




